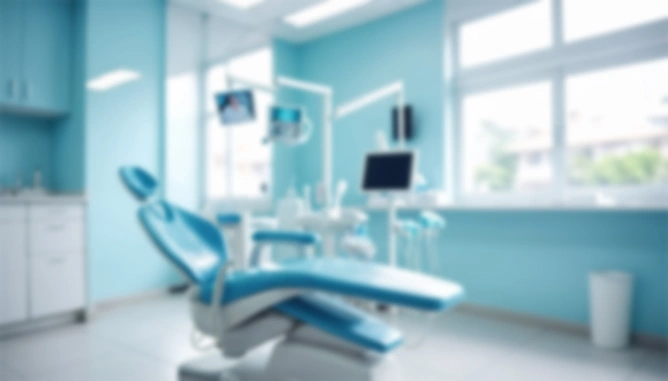Come reagirebbe la NATO se, una mattina, le forze russe occupassero una piccola città dell'Estonia, invocando la protezione dei "compatrioti russofoni"? Sarebbe un'invasione o solo una provocazione? E la NATO sarebbe disposta a rischiare una guerra totale per Narva, una località di 50.000 abitanti al confine con la Russia? Questa è la domanda scomoda sollevata da Carlo Masala, professore di politica internazionale all'Università Bundeswehr di Monaco, nel suo dialogo con la BBC per The Global Story.
Con un tono severo, Masala avverte che l'Europa si trova "nella più pericolosa fase dopo la Seconda Guerra Mondiale, addirittura più tesa della crisi dei missili di Cuba". Secondo lui, la Russia non è soddisfatta dell'Ucraina, ma sta preparando "un test politico" per verificare se l'Articolo 5 ha ancora valore pratico. Secondo le informazioni che cita, Mosca sta espandendo il suo esercito a 1,5 milioni di soldati e produce annualmente "circa 600 missili balistici e da crociera", a un ritmo che supera le necessità del fronte ucraino. Allo stesso tempo, una guerra ibrida si sta già svolgendo sul territorio europeo: attacchi informatici, incendi in fabbriche di armamenti, droni e palloni nello spazio aereo dei paesi baltici - "misure destinate a seminare panico e sfiducia nei governi democratici".
Per Masala, la conclusione è chiara: "Se uno stato membro viene attaccato e la NATO non interviene, allora l'Alleanza è morta. Per la Russia, questa sarebbe la vittoria suprema - non una conquista militare, ma una conquista politica." Carlo Masala parte dall'idea che la Russia non ha bisogno di un'invasione totale per minare la sicurezza europea. Nella sua visione, il maggiore rischio per la NATO non è una guerra convenzionale, ma un "test politico" concepito per mettere alla prova la solidarietà tra gli stati membri. Un'azione limitata, come l'occupazione di una città estone con popolazione russofona, costringerebbe l'Alleanza a decidere se invocare l'Articolo 5 e rischiare un confronto diretto con una potenza nucleare. In sostanza, avverte Masala, la posta in gioco non è la conquista di territori, ma la credibilità: se la NATO esita, perde autorità e legittimità, mentre la Russia vince la guerra senza sparare un colpo.
Questa analisi sta alla base del suo libro "If Russia Wins" (edizione tedesca "Wenn Russland gewinnt. Ein Szenario, C.H. Beck, 2025"), un volume conciso ma estremamente chiaro, che trasforma un esercizio teorico in un avvertimento pratico per i decisori europei. Masala immagina una Russia rinvigorita dopo la vittoria in Ucraina, che testa la NATO attraverso un'incursione limitata nella città di Narva in Estonia. Il libro non è una predizione, ma una dimostrazione lucida di quanto possa essere fragile l'unità occidentale di fronte a un test psicologico e politico. Invece di chiedersi quando inizierà la prossima guerra, Masala propone una domanda più scomoda: cosa farà l'Europa quando l'aggressione non si presenterà come una guerra, ma come un dilemma morale e strategico?
Dall'ordine liberale alla competizione per il potere
Nell'analisi di Carlo Masala, la guerra in Ucraina non è un conflitto isolato, ma il sintomo di un profondo cambiamento di paradigma nella politica globale. Dietro il fronte del Donbass o i bombardamenti di Kharkiv si delinea un confronto molto più ampio: una competizione per regole, istituzioni e modelli di potere. Masala sostiene che il mondo sta entrando in una fase di riconfigurazione dell'ordine internazionale, in cui le guerre convenzionali, gli attacchi informatici e le pressioni economiche fanno parte dello stesso sforzo per imporre una nuova logica geopolitica. L'Europa, intrappolata tra le ambizioni revisioniste della Russia e il ritiro strategico degli Stati Uniti, rischia di essere il palcoscenico dove si decide il destino di questo ordine. Da questo punto di vista, il discorso di Masala diventa una radiografia delle vulnerabilità occidentali. Non si limita all'analisi militare del conflitto, ma segue la catena di causalità che lega il riarmo della Russia, la guerra ibrida condotta all'interno dell'Unione Europea, la frammentazione politica e l'erosione della fiducia pubblica. Ognuno di questi fenomeni è, nella sua visione, un anello in uno scenario più ampio: quello di un test destinato a dimostrare che la NATO non può più garantire la sicurezza collettiva dell'Europa.
L'ordine mondiale, non solo l'Ucraina, dice Masala, il conflitto attuale deve essere visto come una lotta per regole e istituzioni che modellano la sicurezza globale, non solo come una serie di confronti regionali. Per l'autore, la lealtà all'ordine liberale è messa alla prova da potenze revisioniste, e la disputa si svolge tra attori che vogliono mantenere lo status quo e quelli che vogliono ripristinare la sfera di influenza con mezzi politici e militari, non solo attraverso battaglie sul campo. Questa riorientazione della competizione globale trasforma ogni conflitto locale in un test strategico per l'architettura internazionale a lungo termine.
La guerra ibrida continua e si intensifica in Europa, e Masala sottolinea gli strumenti non convenzionali utilizzati sistematicamente, come attacchi informatici contro le amministrazioni locali, sabotaggi a impianti sensibili, incursioni con droni e palloni, e reclutamento di "agenti usa e getta" attraverso canali oscuri. Lo scopo di queste azioni non è necessariamente la distruzione fisica del nemico, ma l'erosione della fiducia dei cittadini nelle istituzioni, la proliferazione della paura e la frammentazione della vita politica interna, in modo che le decisioni di politica estera e di difesa diventino meno ferme.
Il riarmo della Russia crea una finestra di opportunità, argomenta Masala, riferendosi ai piani di Mosca di raggiungere una forza di circa 1,5 milioni di militari e a livelli aumentati di produzione di missili e blindati, ritmi che potrebbero rendere operativo un "test" politico nei prossimi anni. Il problema non è solo la capacità, ma anche l'intenzione, e l'autore avverte che esiste in cerchie russe una diminuzione della riverenza nei confronti dell'argomento della protezione collettiva della NATO, il che rende più probabile la tentazione di verificare la solidarietà dell'Alleanza in condizioni controllate.
Lo scenario di Narva, un esempio di test politico, struttura il rischio in termini concreti: l'occupazione rapida di una città estone a maggioranza russofona, giustificata dalla "protezione delle minoranze", porrebbe l'Occidente di fronte a un terribile dilemma politico, "vale la pena una guerra totale per una città?"; in questo contesto, la minaccia nucleare implicita diventa uno strumento di coercizione. Masala descrive come l'Alleanza potrebbe frammentarsi in tre fazioni, una favorevole a una reazione militare immediata, una che cerca negoziati, e una che preferisce evitare il rischio nucleare, e una tale divisione minerebbe la funzionalità dell'Articolo 5.
Le soluzioni devono essere di capacità e segnali politici, contemporaneamente con resilienza sociale, conclude Masala, l'Europa deve investire rapidamente in difesa attiva e in logistica strategica, come difesa antimissile, capacità di trasporto e sistemi C4ISR, ma anche coordinare segnali politici fermi che scoraggino i test politici. È essenziale che la preparazione prenda in considerazione scenari in cui gli Stati Uniti non rispondono immediatamente, e l'Europa deve essere in grado di agire da sola, o in ampie coalizioni, come un fronte franco-tedesco-polacco-britannico, e allo stesso tempo costruire resilienza sociale contro la disinformazione e il panico interno.
Articolo 5 in termini comprensibili
L'Articolo 5 del Trattato dell'Atlantico del Nord è la clausola fondamentale che definisce il principio della difesa collettiva. Stabilisce che un attacco armato contro uno stato membro è considerato un attacco contro tutti, e gli altri stati si impegnano a fornire "assistenza" nel modo che ritengono necessario, incluso l'uso della forza armata. Non è un meccanismo automatico: l'attivazione dell'Articolo 5 è una decisione politica, che deve essere approvata all'unanimità dal Consiglio Atlantico del Nord. Solo dopo questo passo politico segue la risposta militare, coordinata dal Comando Supremo Alleato in Europa (SHAPE). Nella storia della NATO, l'Articolo 5 è stato invocato una sola volta, dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001, quando l'Alleanza ha riconosciuto gli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti come un atto di aggressione esterna e ha mobilitato risorse a sostegno delle operazioni americane in Afghanistan.
Sebbene l'Articolo 5 non sia stato applicato contro uno stato, la NATO ha frequentemente affrontato "test" ai suoi margini. Russia, Cina, Iran o Corea del Nord hanno compiuto azioni provocatorie che non superano la soglia formale di un attacco armato: violazioni dello spazio aereo, voli aggressivi di aerei da caccia, incidenti marittimi, attacchi informatici e campagne di disinformazione. Questi sono esempi di "zone grigie", in cui l'avversario provoca senza fornire un pretesto chiaro per una reazione militare. Masala ritiene che un tale "caso limite" sia allettante per un aggressore poiché mette alla prova la solidarietà dell'Alleanza e la percezione pubblica, senza costi elevati. Ad esempio, le incursioni russe nello spazio aereo baltico o nella zona del Mar Nero non hanno generato risposte dirette, ma hanno permesso a Mosca di misurare la velocità di reazione e il grado di coesione tra gli alleati.
L'Europa dispone di forze moderne, ma le sue capacità strategiche sono disuguali e incomplete. Nel settore aereo, gli stati europei dipendono dagli Stati Uniti per il trasporto strategico (airlift) e per il rifornimento in volo (air-to-air refueling), elementi essenziali per la mobilitazione rapida delle truppe. Nella difesa antimissile, solo alcuni paesi (Germania, Francia, Polonia, Italia) possiedono sistemi performanti, e la loro integrazione in una rete continentale è appena all'inizio. L'Europa ha anche gravi deficit di munizioni e pezzi di ricambio, dopo anni di sottofinanziamento, e un livello ridotto di produzione interna. Inoltre, le capacità di sorveglianza e riconoscimento (C4ISR), che dipendono da satelliti, droni e comunicazioni sicure, sono in gran parte americane. In altre parole, in caso di crisi rapida, l'Alleanza sarebbe vulnerabile senza l'infrastruttura e la tecnologia messe a disposizione da Washington.
Controargomentazioni e obiezioni alla teoria di Masala
Esistono voci che respingono lo scenario di Carlo Masala, considerandolo troppo pessimista o improbabile. Il campo scettico sostiene che la Russia non ha né la capacità né l'intenzione di aprire un nuovo fronte contro la NATO. Dopo le perdite subite in Ucraina, dicono, l'esercito russo è logisticamente indebolito, ha il morale basso e affronta difficoltà economiche interne. Inoltre, il Cremlino sa che un attacco contro uno stato membro della NATO scatenerebbe una serie di reazioni difficili da controllare, rischiando l'isolamento totale della Russia e la sua distruzione economica. Da questa prospettiva, Mosca utilizza la retorica aggressiva solo come strumento di deterrenza psicologica, non come preludio a un confronto diretto.
Un secondo argomento, frequentemente invocato, è che la NATO reagirebbe inevitabilmente in caso di qualsiasi attacco, per quanto limitato, poiché tutta la sua credibilità si basa sull'applicazione dell'Articolo 5. Gli scettici affermano che l'alleanza ha procedure chiare, catene di comando efficienti e forze multinazionali già dislocate nei paesi baltici e in Polonia. Inoltre, numerosi esercizi comuni hanno dimostrato la capacità di reazione delle forze NATO, e la presenza americana e britannica nella regione renderebbe impossibile un'esitazione collettiva.
La risposta all'analisi di Masala si basa però su una distinzione cruciale: un conto è la capacità militare, un altro è la volontà politica. Il fatto che la NATO possa reagire non significa che reagirà automaticamente. La decisione dipende dal consenso politico dei 32 stati membri, dal contesto interno di ciascuno e dalla percezione del rischio nucleare. La Russia, afferma Masala, non punta sulla superiorità militare, ma sull'ambiguità e sulla paura, sull'idea che un conflitto limitato, accompagnato dalla minaccia atomica, dividerebbe l'Alleanza e inibirebbe una risposta collettiva. Pertanto, il vero test non riguarda la forza, ma la determinazione e l'unità politica.
L'impatto per l'Unione Europea
Lo scenario di Carlo Masala ha conseguenze dirette sulla stabilità dell'Unione Europea, oltre alla dimensione militare. In primo luogo, un test dell'Articolo 5 esporrebbe il rischio di frammentazione politica tra gli stati membri: i paesi del fianco orientale chiederebbero una risposta immediata, mentre alcuni governi dell'ovest, più prudenti o più dipendenti economicamente dalla Russia, pleiterebbero per riunificazione e dialogo. Questa frattura di percezione influenzerebbe la coesione politica dell'Unione, amplificando le tensioni interne già esistenti su questioni come migrazione, bilancio o politica energetica.
Dal punto di vista economico, l'incertezza sulla sicurezza si tradurrebbe in un aumento dei costi di finanziamento, nel rilocalizzazione degli investimenti e nella diminuzione della fiducia nei mercati europei. Parallelamente, la difesa comune e il sostegno all'Ucraina generano già enormi pressioni di bilancio, e un conflitto ibrido prolungato potrebbe deviare i fondi destinati alla transizione verde e all'innovazione verso spese di difesa. Per Bruxelles, la sfida sarà doppia: mantenere la solidarietà tra gli stati membri e, allo stesso tempo, evitare una spirale economica della paura. In sostanza, Masala avverte che il test della Russia sarebbe anche un test della maturità strategica europea, in cui decisioni rapide e unitarie conterebbero più delle dichiarazioni di principio.
Per la Romania, la posta in gioco è particolarmente chiara. Essendo situata sul fianco orientale della NATO e al Mar Nero, la Romania si troverebbe in prima linea in qualsiasi riconfigurazione della sicurezza regionale. La rilevanza dell'Articolo 5 sarebbe percepita non come un principio astratto, ma come una garanzia di sopravvivenza strategica. Nel contesto di un "test limitato" nell'area baltica, Bucarest dovrebbe gestire un doppio compito: rafforzare le proprie capacità militari e mantenere la fiducia pubblica che l'alleanza funzioni effettivamente.
I punti di forza della Romania risiedono nella posizione strategica, nell'esperienza di cooperazione con le forze alleate e nello sviluppo di un'infrastruttura dual-use (civile e militare) che consente la mobilità rapida delle truppe NATO. Tuttavia, le vulnerabilità persistono: interoperabilità tecnologica con i partner, scorte ridotte di munizioni e attrezzature, e la necessità di una comunicazione strategica coerente con la popolazione di fronte alla disinformazione. In una situazione di crisi, la reazione della società dipenderebbe dal livello di resilienza e dalla capacità delle autorità di combattere la propaganda e il panico informativo.
If Russia Wins / Wenn Russland gewinnt. Ein Szenario
Il volume di Carlo Masala è un saggio-scenario conciso (circa 120 pagine) che utilizza l'analisi prospettica per testare la solidità dell'Articolo 5 della NATO attraverso un caso-limite: l'occupazione della città di Narva in Estonia. Il libro propone un esercizio di pensiero strategico su quanto possa essere facilmente scossa un'alleanza quando l'esitazione politica diventa più pericolosa del confronto militare. Carlo Masala è professore di politica internazionale all'Università Bundeswehr di Monaco, co-conduttore del podcast Sicherheitshalber e autore di diversi volumi sull'ordine internazionale, resilienza e difesa europea. I suoi ambiti di expertise includono le relazioni transatlantiche, la politica di sicurezza europea, la competitività strategica globale e la guerra ibrida.
.webp)