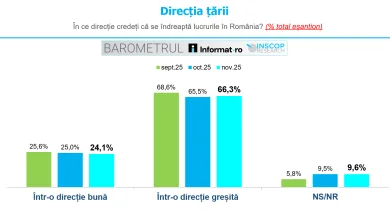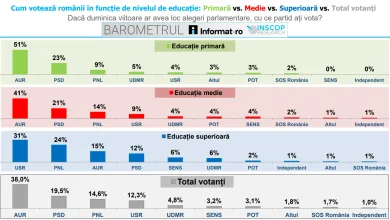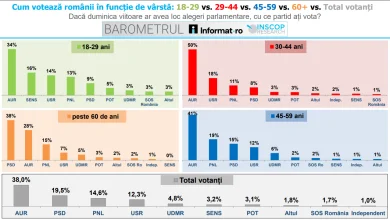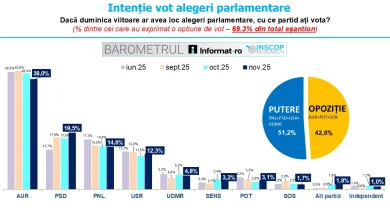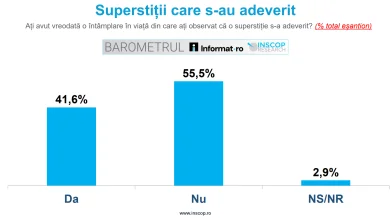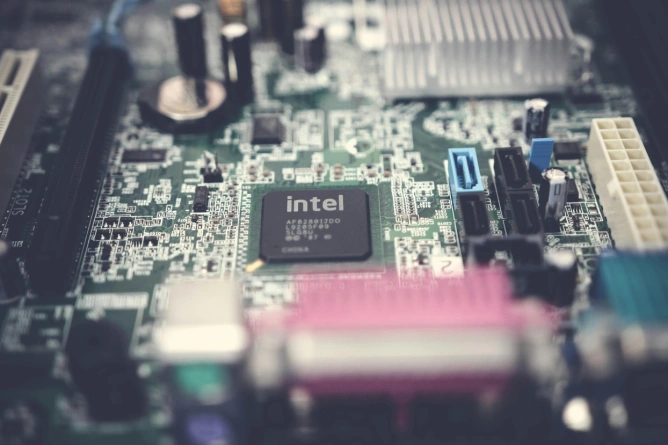Lettura critica dei profili socio-demografici nel BarometroINSCOP - Informat.ro del giugno 2025 sulla spesa pubblica, capitolo proposto da FSP-SNSPA.
Il bilancio non è solo una tabella, ma una mappa di speranze e frustrazioni collettive.
Quando si chiede ai cittadini come dovrebbe essere allocato il bilancio pubblico, essi rispondono non come economisti, ma come membri di comunità segnate da esperienze selettive, diffidenza sistemica e memoria sociale conflittuale. I risultati del Barometro INFORMAT.ro - INSCOP del giugno 2025, che mappa le preferenze della popolazione in merito all'allocazione della spesa pubblica, restituiscono un quadro ingannevolmente coerente: istruzione, sanità e agricoltura sono le aree preferite per gli investimenti, mentre politica estera, assistenza sociale e ordine pubblico appaiono come settori simbolicamente sacrificati.
Ma dietro questi consensi apparenti, emerge una geografia molto più tesa: una società assiologicamente frammentata in cui la solidarietà è negoziabile e le priorità di bilancio riflettono una compensazione per la sfiducia, non un modello di sviluppo coerente.Questo testo propone una lettura socio-politica critica del sondaggio, esplorando:
- le contraddizioni tra le percezioni redistributive e l'immaginario sociale del rendimento istituzionale;
- il ruolo dell'educazione come "budget metafisico" di speranza per il futuro;
- e le spaccature ideologiche che attraversano l'elettorato, mascherate dai punteggi di maggioranza.
1.Priorità illusorie e solidarietà condizionate
Il sondaggio del giugno 2025 sembra, a una prima lettura, indicare una società con priorità chiare e una gerarchia "razionale" di aree di investimento pubblico in cui l'istruzione è al primo posto con l'82,6%, seguita dalla sanità con il 74,7% e dall'agricoltura con il 74,1%. Questi dati, quasi plebiscitari, potrebbero essere interpretati come segni di maturazione civica. Ma un'attenta analisi dei profili socio-demografici e delle contraddizioni interne suggerisce, in realtà, una società che chiede più Stato, ma che mostra una crescente sfiducia nella capacità redistributiva dello Stato.
Da qui la falsa convergenza indicata dai dati di questo sondaggio, perché quando quasi tutti chiedono "di più", nessuno ha fiducia nelle modalità e nella logica di allocazione del bilancio. Ad esempio, la maggior parte del sostegno all'aumento della spesa per l'istruzione proviene da persone con un'istruzione più elevata, residenti nelle grandi città e dipendenti del settore pubblico, cioè proprio le categorie più esposte alla realtà disfunzionale del sistema educativo. L'aumento del budget non è quindi il segnale di una visione nazionale coerente, ma una richiesta di riparazione e protezione proveniente da coloro che ritengono di comprendere meglio lo stato dell'istruzione.
La stessa logica è visibile anche nella percezione della salute, dove gli over 60, gli elettori del PNL e i residenti di Bucarest chiedono un aumento degli stanziamenti di bilancio. Non si tratta di una concezione di welfare pubblico universale, ma di un'espressione difensiva di vulnerabilità. Il sondaggio non misura solo le scelte di bilancio, ma indica una vera e propria psicologia collettiva di sopravvivenza di fronte a uno stato precario.
<Al tempo stesso, l'assistenza sociale rivela il successo di tre decenni di esposizione alle narrazioni neoliberali sul rapporto tra l'economia di mercato liberata dai vincoli sociali e le cause della povertà. È l'area che subisce il maggior rifiuto, con un quarto degli intervistati, il 25,4%, che chiede tagli al bilancio del welfare e solo il 44,8% che vuole aumentarlo. Questo divario indica una profonda erosione della fiducia dei cittadini nella solidarietà mediata dalle istituzioni. Sebbene la Romania presenti alti livelli di povertà e disuguaglianza, la percezione pubblica è dominata da narrazioni di abusi, parassitismo e clientelismo. Questo è sintomatico di una società che ha interiorizzato un'ideologia tronca del merito, in cui solo alcune categorie sono percepite come "degne" di protezione, mentre altre sono escluse dalla comunità morale.Remus Ștefureac osserva in modo pertinente nel comunicato dell'INSCOP che "la tensione tra il sostegno teorico all'assistenza sociale e l'apertura ai tagli in questo settore indica una crisi di fiducia nell'efficacia della redistribuzione". Questa crisi non è solo tecnica ma anche normativa, e riflette l'erosione del cosiddetto patto sociale a favore di un "minimalismo morale" in cui ognuno è lasciato a se stesso.
2.L'educazione come bilancio metafisico: speranza, merito e illusione di mobilità sociale
Tornando all'istruzione, quando l'82,6% dei rumeni dice di volere più soldi per l'istruzione, non esprime un consenso pedagogico o una visione sistemica. Esprime un desiderio collettivo di uscire dall'impasse, una proiezione simbolica di salvezza sociale in assenza di altri orizzonti credibili. L'educazione funziona qui come un bilancio metafisico, come un sostituto per la mancanza di fiducia nella redistribuzione, nella giustizia o nelle prestazioni del mercato.
Il paradosso è che sono proprio coloro che sono stati, in qualche misura, integrati attraverso l'istruzione (i più istruiti, i più urbani, i più urbanizzati) a chiedere a gran voce un aumento del budget. Mentre i gruppi svantaggiati, che beneficerebbero direttamente di un sistema educativo più equo, sono più riservati o assenti dall'area delle richieste. L'istruzione non è più percepita come un mezzo di equilibrio sociale, ma come uno strumento di differenziazione simbolica, una forma di capitale morale che legittima le disuguaglianze esistenti.
Questa dinamica è profondamente plasmata da una versione distorta della meritocrazia, in cui il merito è assunto, non costruito, e in cui l'investimento pubblico nell'istruzione è desiderato nella misura in cui convalida una gerarchia già interiorizzata.
Anche se il sondaggio non valuta direttamente la fiducia nella mobilità sociale, le risposte sull'istruzione la riflettono indirettamente. In una società in cui la fiducia nelle altre istituzioni è bassa, l'istruzione rimane l'unico ambito in cui la speranza può ancorarsi. Ma è una speranza malinconica, quasi avulsa dalla realtà - una nostalgia per un contratto sociale che non è mai stato rispettato.
Quindi "più soldi per l'istruzione" non significa, nella percezione pubblica, riforma dei programmi di studio, investimenti nella formazione degli insegnanti o nelle infrastrutture rurali. Si tratta piuttosto di una richiesta diffusa di ripristino del significato, una forma di compensazione simbolica di fronte al crollo di altri punti di riferimento istituzionali.
3.Ordine e paura: quando il bilancio diventa difesa simbolica
Se l'educazione è la proiezione della speranza, l'ordine pubblico è l'espressione della paura. Quasi il 44% dei rumeni chiede un aumento del budget per l'ordine pubblico, mentre il 15,9% preferirebbe una diminuzione. In questo contesto, si articola una geografia simbolica dell'insicurezza, soprattutto urbana e femminile, che trasforma gli investimenti in polizia e gendarmeria in un rituale di acquiescenza collettiva.
Il paradosso è che l'ordine pubblico non è un tema popolare nel discorso civico, ma piuttosto tollerato come un male necessario. Non ci sono grandi campagne per "una polizia più efficace" o "un sistema carcerario meglio finanziato" nel dibattito pubblico. Eppure la percezione dei rischi sociali - che si tratti di migrazione, criminalità, proteste o caos urbano - attiva un riflesso conservatore che si traduce in un sostegno al bilancio.
Soprattutto tra gli elettori del PSD e a Bucarest, l'ordine viene valorizzato come una barriera simbolica contro il disordine sociale. È un bilancio di prevenzione immaginaria, progettato non tanto per risolvere i problemi reali quanto per offrire l'illusione di una società controllabile.
Chi vuole più ordine? Chi non lo vuole?
Un'analisi per categorie mostra che le donne e gli anziani sono più propensi a sostenere un aumento del budget per l'ordine pubblico, e questo non riflette un'ideologia autoritaria ma una vulnerabilità percepita.
D'altro canto, i giovani, gli utenti di TikTok e gli elettori dell'USR/AUR sono più reticenti. Probabilmente vedono le istituzioni di polizia come potenzialmente abusive, una forma di controllo o di conservazione dello status quo. Il sondaggio configura quindi una frattura silenziosa tra le generazioni e l'immaginario dell'autorità, che può diventare politica in contesti di crisi.
4.Bilanci sacrificati: assistenza sociale e politica estera sotto delegittimazione
In un momento in cui la crisi del costo della vita, la migrazione e la fragilità delle reti di sostegno sono onnipresenti, il sondaggio mostra una profonda ambivalenza sociale nei confronti della solidarietà: un quarto dei rumeni chiede tagli all'assistenza sociale, mentre solo il 44,8% è favorevole a un suo aumento. In un Paese con alti livelli di povertà ed esclusione infantile, questo riflesso è sintomatico del crollo del consenso redistributivo.
Dietro questa preferenza non c'è l'austerità economica, ma l'ostilità morale verso alcune categorie percepite come "illegittime": i rom, gli assistiti cronici, i migranti, i pensionati considerati "troppo numerosi" o le madri single stigmatizzate. Siamo di fronte a una moralizzazione del bilancio, per cui non è richiesta l'efficienza ma la "pulizia" simbolica. L'assistenza sociale diventa così un'area di sospetto, in cui ogni centesimo speso deve essere giustificato pubblicamente più di un appalto di infrastrutture.
5.Politica estera: un lusso percepito
Ancora peggiore è la situazione della politica estera, dove solo il 31,4% chiede aumenti e il 24% tagli. Questo dato potrebbe sembrare naturale in una società segnata dalla deprivazione interna, ma diventa problematico se si considera il contesto geopolitico: guerre di confine, negoziati europei chiave, crisi regionali.
Non a caso, il sostegno alla diplomazia proviene dagli under 30, dalle persone con un alto livello di istruzione e dagli elettori dell'USR e del PNL, cioè proprio da quei gruppi che pensano alla Romania in termini globali, legati alle alleanze, alle migrazioni e al futuro europeo. Gli altri - la maggioranza - sembrano vedere la politica estera come un'inutile appendice di un'amministrazione comunque assente. Il bilancio della politica estera diventa così il simbolo di un'élite che parla lingue straniere ma non rammenda i marciapiedi.
6.Conclusioni: tra lo stato desiderato e lo stato tollerato
Il barometro INSCOP del giugno 2025 non ci mostra solo cosa pensano i romeni dei bilanci. Ci mostra cosa è rimasto dell'idea di contratto sociale in una società stanca di promesse, assiologicamente polarizzata e funzionalmente frammentata.
In apparenza, abbiamo una società che chiede più Stato: più istruzione, sanità, infrastrutture, persino cultura. In realtà, abbiamo una società che vuole uno Stato selettivo, uno Stato protettivo solo per chi è ritenuto "degno" di protezione. L'assistenza sociale e la politica estera sono le prime vittime di questa visione. Non sono solo simbolicamente sottofinanziati, ma anche moralmente delegittimati in nome di una meritocrazia disfunzionale e di un nazionalismo pragmatico.
La spesa di bilancio diventa così un atto di giudizio pubblico: chi se lo merita, chi no? Chi è percepito come utile, produttivo, vicino? Chi rimane fuori dal perimetro della compassione collettiva?
Dietro ai punteggi percentuali si intravede una società in bilico tra due logiche opposte:
- una basata sulla solidarietà sociale universalistica (ancora un ideale astratto),
- e quella di un utilitarismo semplicistico, quasi tribale, che impone la condizionalità del bilancio o l'eliminazione di coloro che sono percepiti come 'extra'" .
Questa tensione tra lo Stato desiderato (riparatore, protettivo, efficiente) e lo Stato reale (clientelare, di controllo) genera una crisi dell'immaginazione politica: i rumeni chiedono "di più" senza credere realmente che lo otterranno. E, forse peggio, senza credere che tutti dovrebbero ottenerlo.
Post-scriptum: Cosa facciamo con questi dati?
Per un politico o uno stratega di governo, i dati di questo sondaggio sono utili solo se interpretati criticamente. Non possiamo costruire una politica sull'illusione del consenso. Quello che sembra un elenco di priorità è, in realtà, una mappa di dissonanze sociali e conflitti latenti di legittimità. La vera domanda non è "dove vogliamo aumentare il budget?", ma "chi altro siamo disposti a includere nella comunità redistributiva?". Finché non risponderemo a questa domanda, tutti i bilanci rimarranno immaginari.Cristian Pîrvulescu
Sui dati analizzati
La fonte di queste riflessioni del capitolo sulla percezione degli stanziamenti di bilancio è il Barometro della Ricerca INFORMAT.ro - INSCOP, condotto tra il 20 e il 26 giugno 2025 su un campione rappresentativo a livello nazionale di 1150 intervistati, utilizzando il metodo CATI, con un errore di ±2,9%. L'obiettivo di questo capitolo proposto da FSP-SNSPA era quello di valutare la percezione pubblica delle priorità di allocazione del bilancio pubblico in 12 aree strategiche.