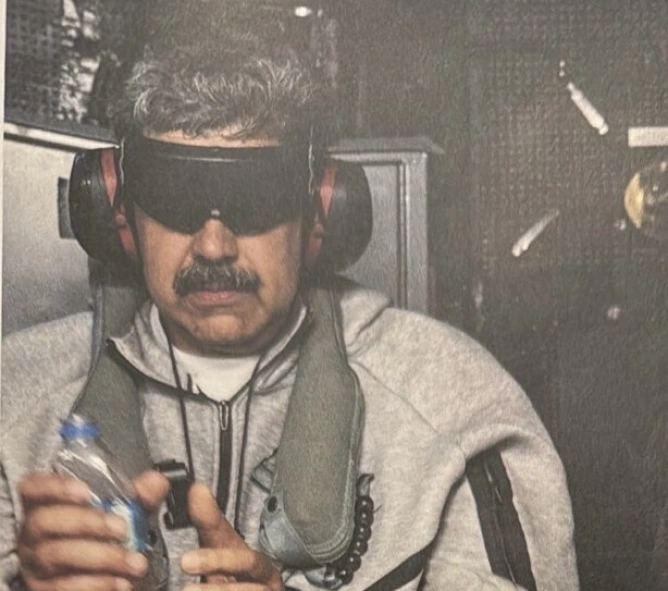6 luglio 11:29

Opinioni
Foto: inscop.ro
L'aspetto bizzarro di questa crisi incombente è che la gente ne è in qualche modo estranea. Due dati recenti dell'INSCOP colpiscono in questo contesto: il 75% dei rumeni afferma che la situazione economica del Paese è peggiorata rispetto a un anno fa; il 44% afferma che la propria situazione finanziaria è peggiorata rispetto allo stesso periodo. Questo spiega perché, guardandosi intorno, si ha la sensazione che tutti sappiano che sta arrivando una crisi, ma pochi si rendano conto che bisogna fare qualcosa per attutire lo shock. Questo divario tra quanti pensano di stare peggio come individui e quanti pensano che il Paese stia peggio dal punto di vista economico porta con sé un meccanismo di coping alle incertezze dell'immediato futuro. Soprattutto perché la seconda metà dell'anno porterà aumenti dei prezzi e nuovi schemi di rendicontazione dei prezzi dell'elettricità, che non lasciano presagire nulla di buono.
Almeno l'inflazione è stata evidente negli ultimi anni, quindi non c'è da stupirsi se solo il 44% dei rumeni si lamenta del proprio stato finanziario. La spiegazione sta probabilmente nel graduale e costante aumento dei prezzi. È una sorta di assuefazione alle difficoltà del nostro territorio che può anche significare resilienza - e probabilmente ci ha aiutato molte volte nella storia - ma può anche significare che a volte non ci rendiamo conto di quali pericoli si nascondono intorno a noi o, c'è questa variante, di quali problemi abbiamo scampato comportandoci correttamente. "Suvvia, signore, stanno esagerando con la pandemia". Non dimentichiamo che la pandemia è iniziata con uno sforzo collettivo e una solidarietà, entrambi spettacolari, per poi concludersi con una rabbia generalizzata e irrazionale nei confronti di uno Stato che comunque è intervenuto in modo più coerente e adattivo di quanto ci aspettassimo, con tutti i pregi e i difetti di quell'intervento. Allo stesso modo, una volta superata, anche la crisi del 2009-2010 non è sembrata così grande e, in molti altri casi, la paura e la mobilitazione iniziali si sono trasformate in zefiro una volta che il pericolo (reale, percepito, valutato correttamente, esagerato - non importa) è passato.
Naturalmente, è comprensibile l'insoddisfazione per il modo in cui le istituzioni - e non solo le istituzioni - stanno reagendo. Ma ci sono casi in cui, in termini comparativi, abbiamo fatto quello che hanno fatto altri Paesi dell'UE, e non necessariamente peggio di loro. Prendiamo il sondaggio INSCOP pubblicato su informat.ro: per anni, con piccole permutazioni e cambiamenti di punteggio sensibili alla realtà immediata (ma non per il futuro), la gerarchia della fiducia nelle istituzioni è stata praticamente la stessa. Tutto nella società rumena degli ultimi 35 anni è cambiato così tanto che la mancanza di variazioni in queste liste di distribuzione della fiducia deve indicare qualcosa che ancora non capiamo. La realtà è che, nonostante tutto ciò che i sociologi commentano da oltre tre decenni, non stiamo più parlando di una crisi di fiducia, perché le cose non sono mai andate meglio o addirittura diverse.
La crisi è anche un concetto terapeutico che, ovviamente, giustifica ogni tipo di misura. E spiega perché abbiamo dei problemi, in modo tale che, prima di arrabbiarsi, le persone pensino che si tratti di una crisi e, per un breve periodo, abbiano una spiegazione che le tranquillizzi. Nell'idea che non si tratti di qualcosa di mai visto prima. Dopodiché, gradualmente, la crisi passa, parallelamente all'erosione della fiducia in chi ha gestito il Paese durante la crisi, nel bene o nel male, non importa. Questa crisi incombente, se non è già iniziata, ha alcuni parametri spiegabili: le spese relative alla mitigazione degli effetti della pandemia, la liberalizzazione del mercato dell'energia, la guerra in Ucraina, ecc. Lo Stato si è indebitato e non ha la capacità desiderata di riscuotere ciò che gli è dovuto. Il mercato funziona ancora. C'è un piccolo paradosso qui, così come c'è un piccolo paradosso nella posizione dell'opinione pubblica sull'adeguatezza della spesa pubblica.
Dall'altra parte della crisi c'è il pubblico, il contribuente, in una forma o nell'altra. E cosa ci dice il pubblico che vuole che accada con la spesa pubblica ora, alle soglie di una crisi/riforma in cui lo Stato sembra fare peggio dei suoi cittadini... Un'altra serie di indicatori dell'ultimo sondaggio INSCOP ci porta a queste risposte. L'83% dei rumeni pensa che lo Stato dovrebbe aumentare gli investimenti nell'istruzione, il 75% nella sanità e addirittura, al quarto posto, il 63% vorrebbe che lo Stato aumentasse gli investimenti nella cultura. Ovviamente tutto ciò dimostra una comprensione dello sviluppo a lungo termine da parte del nostro pubblico. Sembra un Paese ideale con cittadini preoccupati per l'istruzione, la salute e la cultura. Questa è l'interpretazione ottimistica. L'interpretazione pessimistica è legata alla convenienza di questi punti di vista: sia per l'opinione pubblica che per i politici, l'istruzione, la salute e la cultura sono state le priorità per 35 anni. Ma forse i cittadini intendono queste priorità in modo diverso dai politici.
Temo che dietro le formule "investimento nella difesa", "investimento nell'istruzione", "investimento nella sanità", "investimento nella cultura" che vengono sbandierate nell'arena pubblica si nascondano tre agende diverse, difficilmente conciliabili, ognuna con una propria logica: l'agenda dei politici e dei responsabili del bilancio, l'agenda dei professionisti del settore, l'agenda dei beneficiari (il grande pubblico). Ma questo sarebbe già un argomento per una super-ricerca qualitativa.
Almeno l'inflazione è stata evidente negli ultimi anni, quindi non c'è da stupirsi se solo il 44% dei rumeni si lamenta del proprio stato finanziario. La spiegazione sta probabilmente nel graduale e costante aumento dei prezzi. È una sorta di assuefazione alle difficoltà del nostro territorio che può anche significare resilienza - e probabilmente ci ha aiutato molte volte nella storia - ma può anche significare che a volte non ci rendiamo conto di quali pericoli si nascondono intorno a noi o, c'è questa variante, di quali problemi abbiamo scampato comportandoci correttamente. "Suvvia, signore, stanno esagerando con la pandemia". Non dimentichiamo che la pandemia è iniziata con uno sforzo collettivo e una solidarietà, entrambi spettacolari, per poi concludersi con una rabbia generalizzata e irrazionale nei confronti di uno Stato che comunque è intervenuto in modo più coerente e adattivo di quanto ci aspettassimo, con tutti i pregi e i difetti di quell'intervento. Allo stesso modo, una volta superata, anche la crisi del 2009-2010 non è sembrata così grande e, in molti altri casi, la paura e la mobilitazione iniziali si sono trasformate in zefiro una volta che il pericolo (reale, percepito, valutato correttamente, esagerato - non importa) è passato.
Naturalmente, è comprensibile l'insoddisfazione per il modo in cui le istituzioni - e non solo le istituzioni - stanno reagendo. Ma ci sono casi in cui, in termini comparativi, abbiamo fatto quello che hanno fatto altri Paesi dell'UE, e non necessariamente peggio di loro. Prendiamo il sondaggio INSCOP pubblicato su informat.ro: per anni, con piccole permutazioni e cambiamenti di punteggio sensibili alla realtà immediata (ma non per il futuro), la gerarchia della fiducia nelle istituzioni è stata praticamente la stessa. Tutto nella società rumena degli ultimi 35 anni è cambiato così tanto che la mancanza di variazioni in queste liste di distribuzione della fiducia deve indicare qualcosa che ancora non capiamo. La realtà è che, nonostante tutto ciò che i sociologi commentano da oltre tre decenni, non stiamo più parlando di una crisi di fiducia, perché le cose non sono mai andate meglio o addirittura diverse.
La crisi è anche un concetto terapeutico che, ovviamente, giustifica ogni tipo di misura. E spiega perché abbiamo dei problemi, in modo tale che, prima di arrabbiarsi, le persone pensino che si tratti di una crisi e, per un breve periodo, abbiano una spiegazione che le tranquillizzi. Nell'idea che non si tratti di qualcosa di mai visto prima. Dopodiché, gradualmente, la crisi passa, parallelamente all'erosione della fiducia in chi ha gestito il Paese durante la crisi, nel bene o nel male, non importa. Questa crisi incombente, se non è già iniziata, ha alcuni parametri spiegabili: le spese relative alla mitigazione degli effetti della pandemia, la liberalizzazione del mercato dell'energia, la guerra in Ucraina, ecc. Lo Stato si è indebitato e non ha la capacità desiderata di riscuotere ciò che gli è dovuto. Il mercato funziona ancora. C'è un piccolo paradosso qui, così come c'è un piccolo paradosso nella posizione dell'opinione pubblica sull'adeguatezza della spesa pubblica.
Dall'altra parte della crisi c'è il pubblico, il contribuente, in una forma o nell'altra. E cosa ci dice il pubblico che vuole che accada con la spesa pubblica ora, alle soglie di una crisi/riforma in cui lo Stato sembra fare peggio dei suoi cittadini... Un'altra serie di indicatori dell'ultimo sondaggio INSCOP ci porta a queste risposte. L'83% dei rumeni pensa che lo Stato dovrebbe aumentare gli investimenti nell'istruzione, il 75% nella sanità e addirittura, al quarto posto, il 63% vorrebbe che lo Stato aumentasse gli investimenti nella cultura. Ovviamente tutto ciò dimostra una comprensione dello sviluppo a lungo termine da parte del nostro pubblico. Sembra un Paese ideale con cittadini preoccupati per l'istruzione, la salute e la cultura. Questa è l'interpretazione ottimistica. L'interpretazione pessimistica è legata alla convenienza di questi punti di vista: sia per l'opinione pubblica che per i politici, l'istruzione, la salute e la cultura sono state le priorità per 35 anni. Ma forse i cittadini intendono queste priorità in modo diverso dai politici.
Temo che dietro le formule "investimento nella difesa", "investimento nell'istruzione", "investimento nella sanità", "investimento nella cultura" che vengono sbandierate nell'arena pubblica si nascondano tre agende diverse, difficilmente conciliabili, ognuna con una propria logica: l'agenda dei politici e dei responsabili del bilancio, l'agenda dei professionisti del settore, l'agenda dei beneficiari (il grande pubblico). Ma questo sarebbe già un argomento per una super-ricerca qualitativa.